Nel marzo del 2006 ero una quasi 16enne alle prese con il suo secondo anno di liceo. Mi svegliavo presto ogni mattina per prendere l’autobus e fare quell’ora di strada su sedili sgangherati e con altri adolescenti in piena tempesta ormonale, pronti già alle sette del mattino ad emanare il tipico odore pungente di sudore, di piedi e di pantaloncini sporchi dimenticati nel borsone di calcio.
La mia vita era una costante noiosa monotonia che si alternava tra versioni di latino, esercizi di matematica ed episodi di serie TV random che Mediaset ci concedeva gentilmente durante l’ora della merenda pomeridiana.
Ancora non sapevo che la mia vita sarebbe stata sconvolta per sempre da un pilot che la Rai decise magnanimamente di concedere ai suoi fedeli abbonanti durante una sera di fine inverno.
Lo attesi con ansia, bombardata dalle continue presentazioni, sponsorizzata come la serie che aveva sconvolto e stupito l’America.
Fu così che, spinta più che altro da un genuino moto di curiosità, mi sedetti, quella sera del 6 marzo 2006, davanti al televisore del salotto e attesi paziente che un certo Jack Shephard aprisse i suoi occhi in mezzo a un bosco di canne e desse il via a una delle serie TV che più di altre hanno sconvolto ed incantato il panorama televisivo mondiale.

Parlare di cosa sia LOST e di cosa in particolare significhi questo show per me non è facile. Mi tocca mettere a nudo una parte di me stessa, giocare a carte scoperte nello spiegare come i naufraghi del Boening 777 del volo Oceanic Airlines 815 si siano così profondamente insinuati nelle pieghe della mia vita, trasformando irrimediabilmente tutto il mio mondo da telefilm dipendente.
 Con i suoi 121 episodi distribuiti in sei stagioni, LOST ha scalato velocemente la classifica dei miei show preferiti di sempre, facendomi perdutamente innamorare di sé e definendomi irrimediabilmente come maniaca seriale.
Con i suoi 121 episodi distribuiti in sei stagioni, LOST ha scalato velocemente la classifica dei miei show preferiti di sempre, facendomi perdutamente innamorare di sé e definendomi irrimediabilmente come maniaca seriale.
Sono trascorsi ben 12 anni da quando la ABC mandò in onda il pilot, giorno che coincise volutamente con lo schianto dell’aereo sull’isola apparentemente deserta.
Una coincidenza voluta, come già detto, perché in LOST nulla, assolutamente nulla, è lasciato al caso. Ogni elemento, ogni più piccolo particolare e dettaglio è incastrato in una numerologia e in una mitologia che si muovono in un ingranaggio perfetto e logico, in qualche modo.
LOST è un puzzle, un grande puzzle, con milioni di tasselli a cui va trovato il senso, la giusta posizione e l’incastro. Un lavoro oneroso e non indifferente, in cui però lo spettatore non è lasciato solo, ma sono gli stessi personaggi, i superstiti allo schianto, che ci aiutano nel compito.
J. J. Abrams e il suo team non ci ha regalato una semplice serie alla Cast Away, narrando la vita dei sopravvissuti in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
No.
È lo stesso “Guys, where are we?” di Charlie Pace a suggerirci che quell’isola del Pacifico non è in realtà ciò che sembra.
 La voglia di sapere di più, di scoprire i segreti e i misteri che nasconde l’isola sono solo alcuni dei motivi che mi hanno spinta a seguire con costanza la programmazione in chiaro sulla Rai. Purtroppo ero ancora una giovane ed ingenua babbana, all’oscuro del meraviglioso mondo di Internet e dello streaming. Ma le mie lacune si colmarono in breve tempo, quando, durante la stessa estate, mio padre mise la linea veloce in casa e da lì inizia il mio cammino assieme ai personaggi.
La voglia di sapere di più, di scoprire i segreti e i misteri che nasconde l’isola sono solo alcuni dei motivi che mi hanno spinta a seguire con costanza la programmazione in chiaro sulla Rai. Purtroppo ero ancora una giovane ed ingenua babbana, all’oscuro del meraviglioso mondo di Internet e dello streaming. Ma le mie lacune si colmarono in breve tempo, quando, durante la stessa estate, mio padre mise la linea veloce in casa e da lì inizia il mio cammino assieme ai personaggi.
Perché Jack (Matthew Fox), Kate (Evangeline Lilly), Sawyer (Josh Holloway), Charlie (Dominc Monaghan), Locke (Terry O’ Quinn), Jin (Daniel Dae Kim) e Sun (Yunjin Kim), Boone (Ian Somerhalder), Shannon (Maggie Grace), Sayd (Naveen Andrews) e tutti gli altri non si sono solo persi fisicamente, nel bel mezzo del nulla. Ma si sono persi anche spiritualmente e moralmente. Ognuno di loro ha una storia alle spalle, una vita di luce e oscurità, di segreti, bugie, inganni. Una vita prima dell’isola in cui si sono persi. Persi in senso lato. E ora si trovano costretti a far fronte a una doppia perdizione, quella fisica e quella spirituale, posti in una condizione molto simile alle anime tormentate del Purgatorio dantesco: anime che vagano sperdute senza una meta, ma consapevoli di avere come obiettivo quello di tendere al ritrovamento di se stessi.
 E ciò è così profondamente umano, così visceralmente concreto e attuale che risulta impossibile non sentirsi in empatia con ognuno di loro, intraprendendo così, anche noi dall’altra parte dello schermo, quel cammino di espiazione che porta alla redenzione e alla salvezza di sé.
E ciò è così profondamente umano, così visceralmente concreto e attuale che risulta impossibile non sentirsi in empatia con ognuno di loro, intraprendendo così, anche noi dall’altra parte dello schermo, quel cammino di espiazione che porta alla redenzione e alla salvezza di sé.
Ci si può smarrire con una facilità disarmante, così come si perdono chiavi, penne, soldi, post-it con appuntamenti.
Perdere se stessi è più semplice di quanto si creda, poiché non si è immediatamente consapevoli.
Poi arriva qualcosa, paragonabile a un fulmine o a un uragano, che ci fa fermare, ci porta a prendere una pausa da noi stessi e a mettere in stand-by il mondo chiassoso in torno a noi. Rimaniamo da soli con i nostri pensieri, le nostre faccende in sospeso, i nostri rancori, i nostri nodi irrisolti e tutto ciò che possiamo fare è meditare e accettare ciò che ci è capitato, cercando di trovare un modo per fare ammenda.
Ogni personaggio di LOST è un’anima perduta con una storia affascinante, che viene svelata a poco a poco grazie al centric-episodes, una strategia narrativa alla quale si aggiungono spezzoni di flashback che si alternano efficacemente con la vita del personaggio sull’isola. Un modus narrandi fatto di salti nel passato, dislocamenti temporali, viaggi nel tempo e potentissimi cliffhanger da cardiopalma che ha segnato indissolubilmente l’attuale storia televisiva, venendo emulata ed adottata anche da altri show, non solo dal fratellino minore Once Upon a Time.
I rapporti umani sono uno dei fulcri nodali dello show. La loro evoluzione, prima dell’isola – quello tra Jack e suo padre Christian rimane uno dei più complessi e tormentati della serie – e dopo l’isola è così forte e intensa da coinvolgere a tutto tondo, riuscendo a stabilire un rapporto empatico con il telespettatore così profondo come poche volte è capitato con altri show.
Non posso trattenermi dal citare The Constant, uno degli episodi più belli ed emozionanti dell’intera serie. Trovarsi a piangere sul divano non appena inizia a squillare il telefono di Penny è una conseguenza logica e naturale.
Altro protagonista indiscusso dello show è l’isola stessa, carica di misteri e di segreti parzialmente svelati nel corso degli episodi. Alcuni interrogativi sono rimasti ancora aperti, come ad esempio cosa sia effettivamente l’isola stessa. Non si sa davvero, non c’è una risposta certa e definitiva, ma la mitologia e l’alone di misticismo e magia che ha intorno contribuiscono a renderla ancora motore di fascino.
Di una cosa siamo certi. L’isola rappresenta il dualismo che pregna fin dentro le viscere l’intera serie.
Un contenitore di bene e male, luce e oscurità.


John: You’re a man of science.
Jack: Yeah, and what does that make you?
John: Me, well, I’m a man of faith.
Jack Shephard e John Locke.
Due facce della stessa medaglia, così diversi, così opposti, rappresentano nel modo più semplicistico possibile il cuore dello show.
La ragione contro il destino, le spiegazioni razionali contro il salto nel vuoto.
Jack: I don’t believe in destiny.
John: Yes, you do. You just don’t know it yet.
John si arrende al suo destino, consapevole che Qualcuno o Qualcosa più in alto di lui ha già deciso. Ha già stabilito come devono andare le cose.
Jack non ci sta. È un uomo di scienza, un chirurgo, una persona razionale che crede che le cose si possano rimettere a posto secondo una logica dettata dalla ragione.

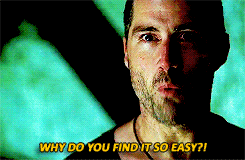
Non a caso è il leader dei sopravvissuti e uno dei personaggi col passato più tormentato e difficile.
Il suo cammino è quello più vicino a quello del telespettatore: noi, dall’altra parte dello schermo, ci immedesimiamo in Jack, ci riesce facile grazie alla sua logica, alla sua razionalità, alla sua mente lucida che non si perde in elucubrazioni filosofiche e metafisiche. È il personaggio che si mantiene in contatto con la realtà. Ed è con lui che arriviamo al finale, rimanendo sconvolti e stravolti assieme a lui, col suo occhio che si chiude, tratteggiando con mano ferma e decisa quel cerchio apertosi con il pilot.

L’uomo di scienza che ha finalmente abbracciato la fede.
Il “We’ve been waiting for you” di John a Jack ci fa capire che oramai il cammino dell’eroe si è concluso, così il nostro assieme a lui.
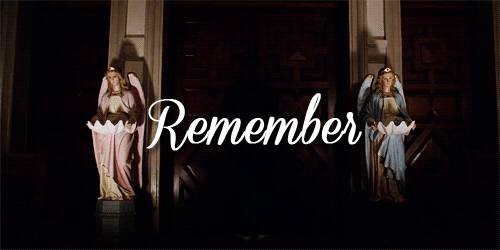

Gli altri superstiti hanno bisogno di Jack, per ricordare ed andare avanti, abbracciare il suo destino.
Ora tocca a noi che siamo dall’altra parte dello schermo. Abbracciare il nostro destino, credere nell’esistenza di un percorso preciso e delineato non imbrigliabile in schemi razionali e logici.
Anche noi, come Jack, dobbiamo fare quel salto irrazionale, quel salto nel vuoto che è in grado di fare un uomo di fede, un uomo perso che alla fine ritrova se stesso.
 Serial Crush Innamorati delle serie tv!
Serial Crush Innamorati delle serie tv!







